Cent’anni e non vederli
- Zetaesse
- 16 nov 2017
- Tempo di lettura: 6 min
Aggiornamento: 7 ott 2022
di ERICA GROSSI

Un affollatissimo «ritratto di truppa» spopola da cent’anni nelle strategie espositive e celebrative della Grande Guerra. Sovraesposizione e citazione sono le cifre estetiche delle fotografie scattate sui fronti italiani e poi fatte oggetto di una specifica retorica visuale di quel conflitto che passa dai corpi e dalle pose dei soldati-figuranti nelle trincee di guerra.
Proprio il Centenario in corso si presta ad essere l’osservatorio privilegiato di quei processi retorici di lungo e medio periodo che, tornando ciclicamente ad alimentare e restaurare l’universo simbolico nazional-patriottico della «patria in armi», continuano da almeno cent’anni a immortalare la scomparsa dell’uomo-soldato dal quadro della Storia o, meglio, la sua trasformazione estetica in mera comparsa nello spettacolo delle celebrazioni.
Le fotografie dell’epoca che affollano le operazioni commemorative di oggi, nella loro moltiplicazione mediatica e circolazione virtuale, infatti, tendono a mantenere l’uomo-soldato nello status quo militarizzato di allora: invisibile ovunque nelle trincee, macchia umana nei paesaggi della «guerra bianca» italiana, in coerenza cromatica con il b/n fotografico dell’epoca. All’anonimato dei soggetti ritratti si somma l’atrofizzazione dell’occhio dell’osservatore, da cent’anni abituato alle stesse citazioni fotografiche, lo sguardo si smarrisce nella moltiplicazione virtuale e spesso perde un punto di vista critico su quelle immagini.
Eppure, a ben guardare – è proprio il caso di dirlo – il linguaggio estetico “a scomparsa” della fotografia dal fronte della Grande Guerra sembra corrispondere e configurarsi alla sistematizzazione della logistica delle trincee e dei camminamenti interrati nei fronti del conflitto. Questa, citando Paul Virilio e i suoi studi su visualità e campo di battaglia, si definisce come una peculiare «logistica della percezione» che impone al soldato – e al soldato-fotografo – di posizionarsi nello spazio belligerante in modo da mimetizzarsi con esso, implicarsi nel terreno fino a camuffarsi con l’ambiente, anch’esso snaturalizzato e militarizzato per ragioni di funzionalità strategica. Quello che conta, infatti, nella moderna guerra tecnologica delle armi a lunga gittata, è disorientare, camuffare, sparire nell’architettura militare del conflitto come nell’«estetica della sparizione» – per citare ancora Virilio – della società militarizzata. La questione topografica, dunque, assume un’importanza centrale nella definizione di «essere invisibile» attribuitasi dal poilu-Apollinaire: interscambiabile, anonimo e silenzioso come le travi che sostengono le pareti della trincea, in una tale contiguità plastica con l’ambiente da preannunciare visivamente la trasformazione del corpo in monumento. Quello appunto che in Italia e in ogni paese europeo del dopoguerra verrà unanimemente invocato, quasi con un beffardo gioco di parole, «Milite Ignoto» ed eternamente destinato a immortalare l’anonimato della massa umana consacrata a farsi «carne da cannone», prima, e monumento-ossario della nazione poi. Concentrando l’attenzione proprio sulle fotografie del conflitto che affollano gli «album della famiglia in armi», questo articolo proverà a far emergere un conflitto tutto interno alle immagini, nascosto o piuttosto silenziato dallo scalpore delle commemorazioni. Si tratta del contrasto tra la logistica visuale sub specie bellica e le strategie espositive della presenza umana in trincea: tra l’estetica della sparizione propria della conduzione della guerra in trincea funzionale alla sopravvivenza dei soldati (mirare, senza esser presi di mira), e l’estetica della memoria pubblica successiva, votata all’ostentazione dell’universo simbolico del nazionalismo italiano, semanticamente attivo ancora oggi e che attinge dalla prima vague retorica dell’epopea risorgimentale elaborata all’inizio del Ventennio.
Tra i miti fondativi della nuova fede laica nella nazione fascista, infatti, non c’è solo la risemantizzazione della Grande Guerra come Quarta guerra d’indipendenza e di redenzione delle terre italiane dal dominio dello straniero austriaco; a fare la sua comparsa sull’Altare della patria in armi è il martirio incarnato nei milioni di caduti il cui il sacrificio come valore è ostentato a decorazione del cuore monumentale della nazione redenta – il Vittoriano di piazza Venezia a Roma – ma la cui identità e umanità sembrano, al contrario, fare la loro scomparsa nella memoria pubblica collettiva.

ESTETICA DELLA SPARIZIONE NEGLI USI PUBBLICI DELLA FOTOGRAFIA DI GUERRA
Una elaborata riflessione nel campo di quelle che oggi si definiscono teoria dei media e storia della percezione applicate al campo militare è già in corso quando esplode la Grande Guerra che si presenta fin da subito come una fantasmagoria di suoni e luci tanto spettacolare quanto, ovviamente, inquietante e tragica. Questa guerra pirotecnica, dunque, muove già le prime considerazioni nel milieu intellettuale europeo, in particolare quello francese e tedesco di fine Ottocento di fronte al tournant tecnologico in chiave militare dell’uomo moderno come Homo Spectator (Mondzain 2013).
In estrema sintesi, gli aspetti più suggestivi di questa riflessione coeva sul rapporto tra corpo, percezione (aisthesis) e dispositivi di mediazione dell’esperienza sensibile – in particolare quelli ottico-acustici della nascente industria della fotografia e del cinema – delineano un modello antropologico secondo il quale la contiguità fisica tra l’uomo e i media produce schemi percettivi storicamente variabili. I dispositivi cioè aumentano, trasformano e configurano la percezione sensibile in modi diversi, modi che costruiscono specifici codici di osservazione della realtà: condizioni del guardare proprie di un soggetto collocato in un luogo dato, il cui sguardo è diretto verso un oggetto preciso.
In un sistema scopico di tal genere, il soggetto si dà un Apparatur funzionale, una propria tecnologia dell’osservazione (Crary 1990): è quello che accade ai soldati in trincea. Applicando questa teoria al posizionamento dell’uomo camuffato nello scavo della trincea di guerra, la dimensione estetica sub specie bellica si presenta con evidenza come un problema di scomparsa.
Ogni azione nella guerra di posizione si riduce infatti a un atto di percezione, in particolare, un atto di presa di visione e di riconoscimento acustico a distanza dell’uomo nascosto nelle trincee che sezionano il campo di battaglia, aderente alle pareti di montagna, che trasformano il paesaggio in un esteso osservatorio. Come con le armi e gli strumenti di protezione in dotazione, come con la difesa rappresentata dalle architetture della trincea, come il binocolo e il visore della camera fotografica, il corpo si configura plasticamente in funzione della condizione fisica nella quale è costretto ad agire per sopravvivere: vedere senza esser visto, mirare senza esser preso di mira, shooting not getting shot, nel senso di “scattare fotografie”.
E infatti la produzione massiccia di fotografie nel Primo conflitto mondiale sembra riflettere questa peculiare logistica della percezione dello spettatore-soldato. Utilizzate non soltanto per il cosiddetto «fronte interno», ovvero per informare e fare propaganda tra i civili lontani dalle linee di guerra, le migliaia di fotografie scattate dai membri del Servizio Fotocinematografico del Regio Esercito e dai soldati fotografi-amateurs posizionati nelle loro feritoie, tra il 1915 e il 1918, ha anche lo scopo di documentare e fornire informazioni utili alla strategia militare stessa. Questa mole di immagini prodotte e riprodotte in serie rappresenta un patrimonio documentale immenso, una stratificata collezione di ritratti nei quali fa la sua comparsa questo essere plasmato dalle condizioni topografiche della guerra di trincea – in particolare, della guerra sulle trincee italiane verticali e bianche di montagna. Ecce homo sub specie bellica.

A sfogliare anche virtualmente questi album della guerra, il montaggio delle singole fotografie produce effetti visuali interessanti che fanno letteralmente saltare all’occhio due elementi tra gli altri che rompono la sequenzialità controllata e la retorica estetica monumentalizzata nelle quali sono stati pensati e realizzati.
Innanzitutto, appare nel suo bicromatismo dominante la congenialità tra fotografia e scenario di guerra, della Grande Guerra: un fenomeno di familiarità e assonanza con cui quegli eventi sembrano aver consacrato e dato avvio al carattere distruttivo del XX secolo. Di quest’aria di famiglia sinistra sono permeati tutti gli album fotografici della guerra che sembrano proporre, per quanto da fronti e momenti diversi, lo stesso vasto e familiare campo di battaglia: ogni paesaggio manda segnali della «guerra totale» in corso; ogni figura incarna lo stesso soldato mobilitato. Proprio l’uomo-soldato è il secondo dato di rottura della parete retorica innalzata a esaltazione della «patria in armi». Come figuranti di una guerra calata dall’alto nelle vite di contadini e operai, questi milioni di militi ignoti sono messi in posa e poi messi in pagina negli album ufficiali per popolare in (modo) uniforme e in eterno lo sfondo belligerante della nazione che si redime attraverso le armi. Come comparse di quella specifica tragedia della storia, finiscono per diventarne icone: dapprima, consegnandosi alla prova della citazione vivente nelle adunate del Ventennio, dove la massa si fa comparsa monolitica sotto i balconi della stessa piazza Venezia dell’Altare della patria. Poi, come “santini” e “figurine” – si pensi solo alla mitografia eroico-sportiva dell’alpino – hanno preso a spopolare nelle migliaia di riproduzioni, nelle illustrazioni editoriali e nel fenomeno di trasformazione della memoria storica in Historytainment sul palcoscenico delle celebrazioni.
I cent’anni trascorsi in cui hanno continuato a perdere di umanità e di identità – la memoria locale, la storia familiare e culturale non hanno potuto tanto da restituire un nome a milioni di sagome – sono però stati sufficienti alla loro cristallizzazione nella memoria visuale della guerra patria e di tutti i suoi appellativi successivi: «guerra verticale», «guerra bianca», «guerra totale».Quello che le strategie di digitalizzazione e messa in circolazione delle fonti archivistiche e documentali permettono di fare oggi e diffusamente è rimettere in luce gli angoli bui di queste fotografie, illuminare gli sfondi e trovare gli scomparsi della storia o meglio, dalla storia.
Come nella Trilogia della Guerra di Gianikian e Ricci Lucchi, l’aura di questi oggetti, da un lato, è disvelata all’occhio atrofizzato dall’effetto straniante del montaggio e della messa in pagina delle fotografie dal fronte. Dall’altro, è proprio la chimica delle gelatine fotografiche ad aver conservato e a far apparire oggi in trasparenza o in contrasto quei figuranti come illuminanti folgorazioni, marionette positive che sfuggono alla composizione generale e possono ancora far balenare particelle di umanità davanti agli occhi distratti dell’osservatore contemporaneo.
*ERICA GROSSI
Vive e ricerca a Milano. Storica di formazione, s’interessa di fonti audiovisive per la storia contemporanea, di cultura visuale e iconografia dei conflitti del Novecento. Ha recentemente pubblicato: Walter Benjamin. Arte, media, filosofia della storia. Per un’archeologia dei tempi moderni (Hachette, 2016).





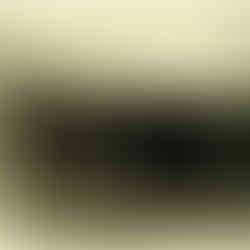













Yorumlar